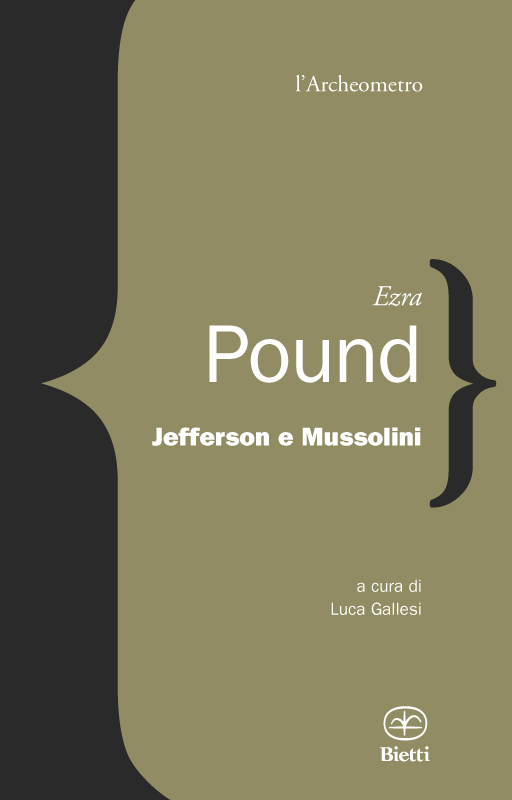Così, per il poeta statunitense, era anche la storia: l’apparizione di alcuni volti luminosi spiccava nella folla dei protagonisti dell’avventura umana. Sigismondo Malatesta, Pietro Leopoldo, Confucio, i più saggi fra gli imperatori cinesi, la dinastia americana degli Adams: sono queste le luci che squarciano il buio, che imprimono senso alla storia. Sono gli alfieri del retto governo e della rivoluzione continua.
Insieme a loro, e contro gli agenti di Usura – da William Paterson, fondatore della Banca d’Inghilterra, ad Alexander Hamilton, suo omologo negli Stati Uniti – il pantheon poundiano dischiude le sue porte a due statisti che più diversi non si può e che sono accomunati nel titolo del più politico fra i saggi del poeta: Thomas Jefferson e Benito Mussolini.
Jefferson and/or Mussolini fu scritto da Pound nel 1933 e pubblicato nel 1935 a Londra. Nel 1944 fu tradotto in italiano, con qualche modifica e titolo cambiato (cadeva quella “o”, come a dire che fra i due non doveva più esserci alternativa, ma solo complementarietà). Ora Bietti ripropone al lettore italiano il testo del ’44, a cura di Luca Gallesi (pp. 125, € 14,00), che firma anche una densa introduzione al testo.
Si tratta di un’operazione benemerita, che ribadisce la parola fine su tanti 
Per non farsi mancare nulla, in compenso, Pound pone Confucio come elemento mediatore fra i due. Un bel rompicapo, ma non per Pound, che coglie il divenire storico in un’unica, colossale visione d’insieme, il cui racconto è poi la “trama” dei Cantos.
La capacità geniale e quasi “eroica” di saper compiere grandi salti fra epoche e luoghi così distanti costituisce la sua grandezza e la sua difficoltà. Difficoltà anche stilistica, perché la lingua di Pound risente potentemente di questa sua velocità, di questa sua immediatezza di intuizione così lontana dal lettore comune, che è sempre in attesa di nessi logici che nei testi poundiani non troverà mai. Non perché non ci siano, ma perché Pound non perde tempo a spiegarli.
Pound ha fretta e quindi scrive di fretta. Il compito di civiltà incombe, bisogna agire, spiegare, scrivere lettere, cercare contatti politici, iniziare azioni diplomatiche, dare alle stampe libri, tradurre testi illuminanti, affiggere manifesti. Nel fascismo, in ossequio alla rivoluzione mussoliniana le cui ragioni il poeta sposerà senza ambiguità. E negli Stati Uniti, in ricordo della rivoluzione jeffersoniana tradita.
L’America delle origini, rurale, frugale, pratica, moderna, ostile ai banchieri, rivive per Pound proprio in quel fascismo che gli appare soprattutto come un movimento pragmatico, popolare, modernizzatore. Una rivoluzione senza preconcetti, attuata da gente che viene dal popolo (Pound benedice il fatto che Mussolini non abbia frequentato l’università), sempre pronta ad ascoltare le idee nuove, come quelle di questo strano poeta giunto dall’America a parlare ai gerarchi di Confucio. Una rivoluzione che ha come nemici solo dogmatici e bigotti. Un po’ come questo libro, che non piacerà ai guardiani delle ortodossie politiche, poetiche ed economiche. Peggio per loro.
Adriano Scianca