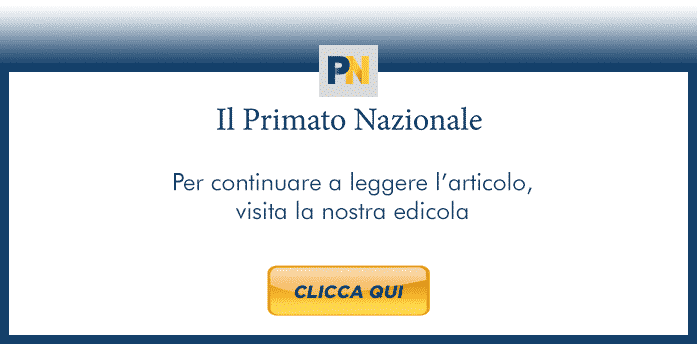Quando Netflix mette in scena un Achille nero, oppure la Murgia parla di «razzismo sistemico», la reazione di una persona normodotata è quella di farsi una grassa risata. Eppure, la «cultura della cancellazione» (cancel culture) è ormai una cosa molto seria. E non c’è più da scherzare: se la «fluidità di genere» è diventata in diverse nazioni legge di Stato (scenario inconcepibile fino a poco tempo fa), è possibile che, tra qualche anno, lo sarà anche la falsificazione storica fondata su quote etniche e revanscismo razziale.
Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di marzo 2022
Contrariamente a quanto si pensa, tutte queste teorie non sono semplici deliri di sparute sette antirazziste. Qualcosa, insomma, di recente, circoscritto ed estemporaneo. Al contrario, sono il risultato di decenni di elaborazione intellettuale e colonizzazione accademica: una lunga semina che ora ha trovato terreno fertile per dare i suoi (avvelenati) frutti. Liquidare il tutto con una risata e una pernacchia, pertanto, è ormai una tattica dal fiato corto: bisogna iniziare a fare i conti con questo sistema di pensiero. Che sarà assurdo quanto si vuole ma – è un fatto – sta conquistando un’egemonia culturale sempre più vasta.
Gli studi postcoloniali contro ogni identità
Alla base della cultura della cancellazione c’è un insieme di indirizzi di ricerca che, specialmente nel mondo anglosassone, sono ormai diventati materia d’insegnamento universitario, con tanto di cattedre, sub-cattedre e fondi sempre più consistenti. Questa costellazione di (nuovi) indirizzi è costituita da tre settori disciplinari fortemente interconnessi: postcolonial studies, subaltern studies e cultural studies. È quasi superfluo rimarcare che questi ambiti di ricerca si intersecano anche con altre discipline quantomeno controverse, come ad esempio i gender studies, ossia gli studi di genere.
Naturalmente non è possibile analizzare qui nel dettaglio le varie teorie partorite da tutte queste correnti di pensiero. Ben più utile, semmai, è identificare il loro denominatore comune. E cioè il concetto di othering, o «altrizzazione». Questo termine orribile – come del resto tutti quelli coniati dagli intellettuali postmarxisti – indica quel processo con cui un soggetto dominante costruisce l’immagine dell’Altro e, parallelamente, rafforza la propria identità: secondo questa interpretazione, l’Altro verrebbe quindi assolutizzato, caricandolo di tutti quei caratteri negativi che, invece, non appartengono a «noi», che siamo migliori e superiori. In proposito Gayatri Spivak, decana degli studi postcoloniali, parla di «essenzialismo strategico», ossia una cristallizzazione dell’identità che ha un unico scopo: perpetuare una gerarchia sociale immobile e un ingiusto rapporto di subordinazione. Detto in soldoni: i colonizzatori, per cementare la propria comunità e rassicurare i suoi membri, si immaginano i colonizzati come il Totalmente Altro, che viene così relegato nel regno dell’inciviltà e della barbarie.
Per i paladini del pensiero unico, questo processo – che serve a consolidare il potere dell’oligarchia egemone a scapito delle classi subalterne – è ovviamente quanto di più deprecabile possa esistere: per i postcolonialisti, infatti, l’identità non può mai essere qualcosa di definito (o definibile), ma è sempre un’entità liquida e soggetta a contaminazioni. Non a caso, un altro concetto-chiave di questa scuola di pensiero è quello di «ibridazione». Che cosa vuol dire tutto questo? Che distinguere tra un «noi» e un «loro» – processo normalissimo per qualsiasi tipo di comunità, dai gruppi etnonazionali ai salotti dei radical chic – sarebbe sia scientificamente scorretto che moralmente censurabile (in tutti i sensi). E, pertanto, ogni identità va prontamente decostruita per ristabilire l’unità indivisibile della cosiddetta «umanità».
La fabbrica dell’odio
Il lettore più attento avrà perfettamente còlto quali sono i riferimenti culturali degli studi postcoloniali: postmodernismo (Foucault e Derrida), semiotica (Eco), marxismo (Gramsci e Sartre), teoria femminista (Butler e de Beauvoir), etnografia strutturalista (Lévi-Strauss), teoria critica (Adorno) e post-strutturalismo (Lacan). Un biglietto da visita che lascia ben poco spazio a fraintendimenti.
Al di là, però, di questi padri precursori, che vengono variamente intesi e variamente reinterpretati, gli studi postcoloniali traggono alimento soprattutto da due grandi classici del pensiero antieuropeo: I dannati della terra di Frantz Fanon (1961) e Orientalismo di Edward Said (1978). Fanon (1925-1961), un francese originario della Martinica, è unanimemente riconosciuto come l’ideologo principe dell’anticolonialismo e del terzomondismo, nonché come uno dei pionieri della «coscienza nera» (o négritude) da opporre al dominio degli imperialisti bianchi. Said (1935-2003) invece, palestinese di nascita e statunitense di passaporto, è rimasto famoso per aver elaborato il concetto di «orientalismo». Che, nel suo pensiero, non è tanto la disciplina scientifica che si occupa della storia delle civiltà orientali, bensì l’immagine stereotipata dell’Oriente costruita dagli occidentali. Nell’interpretazione degli intellettuali bianchi, spiega Said, l’Oriente sarebbe sempre luogo di tirannia, oscurantismo, arretratezza ed effemminatezza. Al contrario, l’Occidente europeo sarebbe l’emisfero in cui regnano libertà, civiltà, progresso, virilità e così via.
Benché l’opera di Said non manchi di spunti molto interessanti, si percepisce chiaramente l’accusa di «etnocentrismo» rivolta a tutti gli europei, colpevoli di giudicare le altre culture sulla base del proprio sistema di valori. C’è solo un piccolo problema: che non esista uno sguardo from nowhere, ossia una prospettiva totalmente neutrale, è chiaro anche agli alunni delle elementari. Dopotutto, in base a quali criteri gli europei dovrebbero valutare le altre culture se non attraverso i propri? Per questo motivo, l’accusa di etnocentrismo non può che rivelarsi per quello che realmente è: un’accusa rivolta a una sola civiltà, quella europea. Una civiltà, va da sé, geneticamente oppressiva e imperialista.
L’obiettivo degli studi postcoloniali
Non è un caso che una delle pietre miliari degli studi postcoloniali sia Provincializzare l’Europa di Dipesh Chakrabarty (2000). L’intento dello storico indiano – che, come è costume dei suoi colleghi, mischia spesso e volentieri scienza e militanza ideologica – non è quello di provincializzare il Vecchio continente da un punto di vista politico: «Quell’Europa, potremmo dire, è già stata provincializzata dalla storia», sentenzia Chakrabarty con invidiabile sicumera para-hegeliana. No, «l’Europa che intendo provincializzare, o decentrare, è una figura immaginaria che rimane profondamente intessuta nelle forme schematiche e stereotipiche costitutive di alcuni dei modi di pensare abituali» degli intellettuali occidentali: «In qualunque parte del mondo ci troviamo, è impossibile pensare il fenomeno della “modernità politica” […] senza ricorrere a categorie e concetti che affondano le radici nelle tradizioni intellettuali, e perfino teologiche, europee».
L’intento è anche lodevole: è perfettamente legittimo – e scientificamente condivisibile – analizzare una data civiltà sulla base dei suoi specifici criteri culturali. Tuttavia, e qui casca l’asino, nessuno degli intellettuali postcolonialisti riesce davvero a fare a meno della tradizione di pensiero che vorrebbe decostruire e decentrare. E non è certo colpa degli europei se Cartesio, Copernico, Galilei, Kant, Newton, Ranke e gli altri padri fondatori della scienza moderna erano, appunto, europei. C’è poco da fare: si può gridare all’etnocentrismo quanto si vuole, ma senza i criteri scientifici elaborati dalla filosofia europea, semplicemente, non si può fare scienza. Al massimo si può leggere nelle stelle o ululare alla luna.
Noi e gli altri
Purtroppo, per mancanza di spazio, non ci è possibile illustrare tutte le altre teorie della nebulosa postcolonialista. Ciò nondimeno, vale la pena di fare due brevi riflessioni. Tanto per cominciare, il processo di «altrizzazione» – tanto deprecato da chi interpreta come intrinsecamente violenta ogni forma di «costruzione dell’Altro» – viene messo in moto con molta disinvoltura dagli stessi soggetti che lo denunciano. In particolare, quando si tratta di attaccare il nemico di turno: vietato generalizzare se si parla di neri, donne, islamici e minoranze varie, ma va benissimo squalificare come «fascisti» tutti coloro che non aderiscono al culto globalista e non si inchinano al feticcio della «diversità». Molto, troppo comodo.
Ma se qui abbiamo a che fare con mezzucci da pezzenti nell’anima, la sinistra rimane vittima di questi processi anche quando non lo vorrebbe. Stiamo parlando della cosiddetta «orientalizzazione interna». Che cosa vuol dire? Si tratta del…