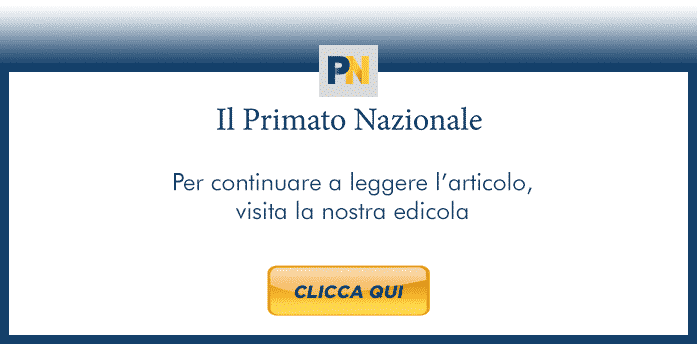Autore, nel 2005, del seminale Biopolitica, il nuovo paradigma (Seb) e ora di nuovo in libreria con I sentieri della tecnica (Centro produzioni Moira), Stefano Vaj è un autore che da tempo affronta, in modo originale, le implicazioni filosofiche e politiche della tecnoscienza sull’esistenza umana. Un tema, quest’ultimo, tornato potentemente d’attualità in un’epoca di ecocatastrofismo e green washing come quella presente. Lo abbiamo intervistato per sapere quale può essere la terza via tra l’ambientalismo politicamente corretto e la negazione individualistica di qualsiasi preoccupazione ecologica.
Questa intervista è stata pubblicata sul Primato Nazionale di novembre 2021
Cosa pensi dell’ecologia alla Greta Thunberg e degli argomenti di Friday for future?
«Il gretinismo, secondo la facile battuta dei suoi critici italiani, è un fenomeno socioculturale importante, che costituisce la saldatura simbolica di innumerevoli interessi, idee e tendenze all’interno del sistema occidentale. In realtà, rappresenta uno sviluppo della mentalità ecologista, più che della relativa tematica, atteso che i gas serra antropici cui il riscaldamento globale viene attribuito dalla vulgata dominante tipicamente non sono inquinanti, nel senso di velenosi, e che lo stesso riscaldamento del pianeta semplicemente favorisce alcune specie, o alcuni tratti genetici, rispetto ad altri.
Ma gli aspetti decisivi del fenomeno sono quelli che combinano l’illusione di una partecipazione politica “dal basso” (gli adolescenti che “scioperano” con l’incoraggiamento di presidi, polizie, ministri degli Interni, media e istituzioni internazionali) con uno sviluppo esponenziale di tre trend fondamentali del Brave New World in via di affermazione. Il primo, più banale, è l’identificazione di un tema che giustifichi e moralizzi la “fine del progresso”, inteso anche come miglioramento – o anche solo mantenimento – delle condizioni di vita della massa della popolazione. Il secondo ovviamente è il mondialismo, ovvero l’utilizzo di supposti interessi planetari per imporre politiche universali a scapito della sovranità e autodeterminazione locale. Il terzo è la negazione della sovranità popolare, attraverso un’interessante perversione del principio secondo cui la comunità non è espressione solo di chi ne fa attualmente parte, ma anche dei loro predecessori e dei loro discendenti futuri.
Ma qui naturalmente la questione è il fatto semplicemente di piegarsi alle opinioni di “those who know better”, i chierici (scientifici, economici, giuridici) dell’oligarchia internazionale. Alle posizioni e indicazioni di costoro è così istericamente pretesa un’adesione fideistica, al punto che diventa blasfemo e inaccettabile anche solo scomporre e analizzare gli aspetti in materia di fatti e di valori ricomprese nella questione, tanto che vengono apertamente ripresi il linguaggio, gli anatemi e gli inviti all’ostracismo relativi al preteso “negazionismo” in senso storico.
Ora, non vi è chi non veda che le possibili domande sono molteplici. È davvero in corso un riscaldamento globale? Se sì, è davvero di origini antropiche? Se sì, è un male? Per chi, e per cosa, è davvero un male (paradossale a tal proposito lo schieramento in prima linea di regioni come il Canada o la Scandinavia)? Quanto è un male, ovvero: che prezzo siamo disposti a pagare per evitarlo, ivi compreso in termini di vite umane non salvate o non nate a causa del dirottamento di risorse sul problema? E quale sarebbe il punto di equilibrio tra l’espansione dell’investimento in questione e la riduzione della temperatura così conseguita? Infine, davvero la riduzione delle emissioni è un risultato ottenibile con le politiche attuali, ed è il modo migliore o l’unico di affrontare il problema? Ora, qualsiasi tentativo di approfondire ciascuno di tali aspetti vede immediatamente azzittiti anche mostri sacri dell’establishment scientifico italiano, abituati a trovare facilmente l’orecchio dei principali media, come Rubbia o Zichichi».
A Greta la destra, variamente intesa, risponde sostanzialmente in due modi: da una parte in modo «trumpiano», negando qualsiasi problema di natura ambientale e tessendo sostanzialmente l’elogio del Suv lasciato acceso in doppia fila, dall’altro declinando in modo «identitario» il tema della decrescita, della tutela del paesaggio, della biodiversità. Cosa pensi di questi due approcci?
«Nel primo caso citato, la reazione conservatrice alla campagna internazionale che ha come epicentro e simbolo Greta Thunberg è improntata da un lato a livello individuale a un tipo di “trasgressione asociale”, che ovviamente non è traducibile in una scelta collettiva, dall’altro a una politica simile a quella dei passati tentativi della lobby del tabacco di “ritardare, offuscare, falsificare”, in vista di interessi politici ed economici a breve e brevissimo termine. Nondimeno, ha il pregio se non altro di non rafforzare il conformismo sull’argomento.
Le posizioni invece che si apparentano a nostalgie sempre risorgenti per passati preindustriali, rurali, tolkieniani, più o meno immaginari, poco hanno da dire sulla questione. Agricoltura e allevamento hanno cambiato, e in un certo senso “danneggiato”, l’ecosistema, il paesaggio e la biodiversità molto più di quanto l’abbia fatto l’industria, e l’accettazione della stagnazione, del declino, o magari dell’estinzione, in vista del mantenimento della temperatura media al livello (del tutto arbitrario) del pianeta nel 2010, o della ipotetica restrizione della “impronta ecologica” della nostra specie, è una posizione certo legittima, ma sappiamo quale fortuna il processo abbia portato ad esempio ai dinosauri».
È possibile un’ecologia «futurista», non regressiva né bucolica o reazionaria? E quali dovrebbero essere le sue linee guida, tanto filosofiche che pratiche?
«Come mi è capitato di scrivere qualche anno fa, l’ecologia – a differenza dell’ecologismo – è una scienza, e come tale per definizione è suscettibile di fondare una tecnica. Oggi l’intera biosfera umana è direttamente e indirettamente sotto l’influsso della nostra specie, e questo significa che non esiste davvero alternativa al fatto di farsi carico del relativo dominio ed estenderlo consapevolmente. In questo, la visione del mondo sottesa al principio di precauzione suggerisce che “tenere giù le mani” il più possibile sia una scelta valida di per sé, in quanto rimuove le responsabilità umane al riguardo indipendentemente dagli esiti fausti o infausti di tale opzione. Tenere giù le mani d’altronde significa non solo applicare un tendenziale proibizionismo a qualsiasi cosa non passi test di “sicurezza” esponenzialmente sempre più stringenti, ma soprattutto far sì che le “decisioni” siano sottratte per quanto possibile a scelte umane e politiche ed affidate a regole giuridiche universali e meccanismi impersonali come quelli del Mercato.
L’approccio in questione è ovviamente disumanizzante, rispetto a ciò che è stato caratteristico della nostra specie almeno a partire dalla rivoluzione neolitica. Ma è anche potenzialmente catastrofico, perché si riduce a fare un uso idealmente sempre più oculato e prudente di risorse comunque limitate. Rispetto a questo, l’alternativa, più che nel “proteggere” un ambiente, un paesaggio o una biodiversità dati, sta nell’idea di plasmarli e svilupparli e magari ricrearli (ripristinando artificialmente scenari che non esistono già più), secondo linee considerate desiderabili per…